
Era una sera di maggio. Stavo attendendo Giuseppe Sinopoli, nel salotto della sua casa, a Roma. Gli occhi vagavano sui molti libri, disposti negli scaffali e aperti sul tavolino, che rivelano in particolare la sua passione per l’archeologia, così grande da averlo spinto a studiare per ottenere una laurea anche in questa disciplina. Quando Giuseppe Sinopoli spalancò la porta, era raggiante. Ritornava da Vienna, dove, due giorni prima, aveva colto uno strepitoso successo, al Theater An der Wien, con lo Stabat Mater di Rossini. Sinopoli era stato invitato a dirigere questo concerto sull’onda del trionfo ottenuto con l’Orchestra Filarmonica di Vienna durante la tournée che il celebre complesso austriaco aveva tenuto in Giappone, pochi mesi fa, per festeggiare i centocinquant’anni dalla sua fondazione.
“Questi impegni con la Filarmonica viennese hanno segnato una sorta di ritorno alle origini, per Giuseppe Sinopoli: a quella Mitteleuropa dove egli si era formato. Il ritorno prelude a prossimi impegni viennesi, sia sul podio dell’orchestra, nella sala del Musikverein, sia nella buca dell’ Opera di Stato, dove – è noto – i Wiener Philharmoniker si esibiscono come Wiener Staatsopernorchester.
Vienna è sempre stata uno dei punti di riferimento della mia attività: ho studiato a lungo il pensiero filosofico, in particolare fino a Wittgenstein, quindi quell’ambiente culturale che trova negli scritti di Nietzsche, Hofmannstahl , Schnitzler, Altenberg, tutta una serie di modi di esprimersi che riflettono il mondo della Finis Austriae.
Terminati i miei studi di Medicina, mi sono trasferito a Vienna e vi sono rimasto per molti anni, per cercare di sentire da vicino questo ambiente culturale che mi affascinava molto e che, nella musica, per me si rifletteva soprattutto in due interessi: quello per Mahler e quello per Wagner.
A Vienna ho studiato direzione d’orchestra con Hans Swarowski e mi sono avvicinato alla Neue Wiener Schule, durante un Corso tenuto da Friedrich Cerha. In particolare, mi interessava Alban Berg: il mio primo anno di soggiorno viennese era stato reso possibile da una borsa di studio della Fondazione “Berg” – a quel tempo ,viveva ancora la vedova del compositore – allo scopo di redigere un saggio su Lulù. Il titolo della ricerca sarebbe stato: «Il concetto di serpente e il concetto di Eva nella Lulù di Alban Berg>>. Un tentativo di elaborare una critica dell’opera che non ripetesse esattamente quanto si poteva dedurre dall’analisi della partitura, ma cercare di individuare aspetti nuovi, di scoprire relazioni nuove.
Successivamente ho conseguito i primi successi all’Opera di Vienna, dirigendo in particolare Verdi ( Attila, Macbeth, Aida) ma pure Tannhauser di Wagner e Manon Lescaut di Puccini.
La mia prima Tournée in Giappone l’ho compiuta con l’opera di Vienna, per dirigere Manon Lescaut, che venne accolta in modo entusiastico.
Poi, per tutta una serie di coincidenze, si è fatalmente realizzato ciò che tutti i viennesi di adozione conoscono. Da Vienna, ad un certo momento bisogna allontanarsi… per poi ritornarci… Negli scorsi mesi, i Wiener Philharmoniker mi hanno invitato a sostituire Carlos Kleiber, che si era ammalato, per accompagnarli in Giappone, in occasione della tournée del Centocinquantesimo. E lì è nato un rapporto bellissimo, molto particolare, che avrà importanti sviluppi in futuro, un rapporto caratterizzato da una grande serietà professionale ma pure da un profondo interesse per la musica.
Che i Wiener Philharmoniker abbiano un suono del tutto particolare, diverso da quello delle altre orchestre, è noto. Ciò che affascina ancora di più, è la capacità che hanno questi musiciti di proiettare un’impronta di umanità, quasi di umanesimo, nel loro modo di suonare. Le orchestre americane, inglesi, tedesche, hanno sempre, nel loro suonare, una certa gestualità esteriore, anche nel momento in cui si crea la grande arte. Nei Filarmonici Viennesi, invece, esiste una compartecipazione, una commozione quasi interiore. Lo stesso fenomeno si verifica con la Siichsische Staatskapelle di Dresda: si tratta della capacità di entrare profondamente in quello che si fa, pur non lasciando apparire il peso i questo lavoro. Il risultato lo avverte dalla maniera in cui si suona. Il risultato ultimo, quindi, è il suono. Dietro questo suono, esiste un atteggiamento culturale, non ancora intellettuale: è il lasciarsi andare a quella “profondità” di cui Nietzsche spesso accusava i tedeschi, ben sapendo però che era uno dei più grandi tesori che essi possedessero. Tale capacità è completamente sparita dai tedeschi, almeno nella musica. Con due eccezioni: i Wiener Philharmoniker e la Siichsische Staatskapelle Dresden”.
I Wiener Philharmoniker hanno avuto centocinquant’anni per assorbire questo spirito, costituito da un’infinità di elementi. Lei stesso, vivendo in questa città, leggendo, studiando, ha avuto modo di assimilare la sua “viennesità”. Forse il “reinnamoramento” dei musicisti viennesi nei Suoi confronti, e viceversa, rappresenta qualcosa che sarebbe dovuto succedere: da una parte una persona, dall’altra cento persone. Ma tutte parlano la medesima lingua…
Credo sia successo proprio questo. Quando lavoro con quest’orchestra, non penso né parlo in tedesco, ma in viennese. Il viennese è una lingua differente dal tedesco, come lo sono taluni percorsi mentali, gli atteggiamenti. Dei Wiener Philharmoniker, sorprende anche la cultura extra-musicale di una gran parte dei suoi membri, che vantano dottorati in musicologia o in altre discipline umanistiche: è forse l’orchestra con la maggior concentrazione di persone veramente colte. E questo si avverte anche nel modo di suonare.
Leggendo il programma della tournée in Giappone con i Wiener Philarmoniker, incontriamo quattro nomi della grande tradizione sinfonica mitteleuropea, Schubert, Bruckner, Mahler, Strauss. Per una persona come Lei, che si è sempre interessata a questi autori, dev’essere stato meraviglioso lavorare a lungo e intensamente tale repertorio con l’ orchestra che virtualmente l’ aveva generato.
L ‘altro giorno, dopo il concerto rossiniano al Theater An der Wien, Werner Resel, violoncellista e presidente dell’orchestra, mi diceva: «Maestro, Lei ormai è uno dei nostri direttori, e quando viene da noi, deve sentirsi a casa sua, come noi con Lei ci sentiamo a casa nostra. Lei sarà sempre accolto come uno della famiglia». Penso che il nocciolo della questione stia in quest’idea dell’essere a casa propria, con i Wiener Philharmoniker. Con questa orchestra, ho provato veramente la sensazione di trovarmi a casa.
Dirigendo i Wiener, entrando in sintonia con tutte le componenti parallele e trasversali del loro far musica, vengo colto da tutta una serie di emozioni che non ho mai provato con altre orchestre: sono affascinato dal fatto che questo suono e questa pulsione ritmica derivano dal modo in cui questi musicisti si pongono davanti alla musica. Avevo nella mia mente la realizzazione ideale di un “Trio” della Prima Sinfonia di Mahler, ma l’ho sentito realizzato solo quando mi è capitato di dirigerlo con loro. E ho un’orchestra meravigliosa come la Philharmonia di Londra, un complesso eccezionale che amo moltissimo!
Anche per la Settima di Bruckner, mai avevo sentito il primo tema del primo movimento suonato come lo sanno suonare i Filarmonici Viennesi: è quasi inimmaginabile che un’orchestra possa unire suono, ritmo, fraseggio, in modo tanto mirabile. Il che,
Il che,
Giuseppe Sinopoli con Cheryl Studer in occasione della presentazione alla stampa dell’incisione della straussiana Salomè.
paradossalmente, comporta per il direttore d’orchestra una particolare difficoltà: questa è un’orchestra che… non vuole essere diretta. Il direttore, con i Wiener, non deve scandire il tempo, ma suggerire un tipo di fraseggio: la sua gestualità, quindi, non dev’essere esteriormente spettacolare, non deve sbacchettare con un gesto più o meno estetico, ma deve suggerire la frase, suggerire il modo di pensarla, il che non è nemmeno sempre necessario. Hans Swarowski aveva l’abitudine di dire che un direttore, l’orchestra può solamente disturbarla. Con i Viennesi, battere il tempo serve solo al direttore per andare avanti e all’orchestra per… di struggere il proprio suono.
Certo, per lavorare sulla frase e sulla forma, bisogna avere delle idee che convincano i musicisti. Se questo avviene, se il direttore abdica al ruolo di “direttore-dittatore” e fornisce pensieri, emozioni, ecco che l’orchestra trasmette quella sensazione di trovarsi in comunione con il direttore.
Esiste un’altra orchestra, a cui Lei si è avvicinato soprattutto per la necessità di “vibrare con essa”: la Sachsische Staatskapelle Dresden. Lei aveva risposto positivamente all’invito dei responsabili dell’orchestra di assumere l’incarico come direttore stabile, ma tale decisione costituiva un salto nel buio (il Muro di Berlino non era ancora caduto ), nell’ambito di una realtà politica ed economica decisamente problematica, quale quella dell’ex DDR…
Di questa orchestra, mi interessava la maniera di far musica: ero affascinato dal silenzio che si creava fra i musicisti durante i concerti e durante le prove. L’orchestra di Dresda vive il far musica come un fatto rituale . Perché la musica è un fatto rituale: è una delle pochissime cose che, al giorno d’oggi, hanno ancora una simile caratteristica. Per ascoltare musica, per fare musica, ci si reca in un particolare spazio (chiamato auditorium o teatro), che ha una determinata conformazione, che spesso ha una struttura architettonica con riferimenti simbolici; si va vestiti in un determinato modo (e se non lo si fa, ciò avviene per reazione, quindi si segue anche in tal caso un atteggiamento rituale); si inizia a una certa ora. All’opera, si ritorna a un tempo originario: si torna a pensare e a rivivere situazioni che in passato erano normali e che oggi forse non si ha più il coraggio di rivivere. Ascoltando musica sinfonica e da camera, ci si confronta con esperienze creative e emozionali che testimoniano, al pari dell’opera anche se in forma più astratta (non esiste la vicenda del libretto, a cui riferirsi), i momenti più vitali e più cruciali della vita dei compositori. La musica non è soltanto un’esperienza creata per far piacere al pubblico, è la documentazione delle crisi di coscienza di chi l’aveva composta.
La terza orchestra che Lei dirige, la Philharmonia di Londra, è, in ultima analisi, un’orchestra di carattere mitteleuropeo, perché, pur non avendo che poco più di cinquant’anni, è stata forgiata da due personalità come Karajan prima e Klemperer poi.
La Philharmonia che avevo preso in mano dieci anni or sono era rimasta mitteleuropea nelle persone, visto che vi suonavano ancora parecchi musicisti che avevano lavorato con Klemperer. Tuttavia, alla morte di quest’ultimo, l’orchestra si era come disorganizzata. Quando Riccardo Muti cominciò a lavorare con la Philharmonia, come successore di Klemperer, gli toccò riorganizzarla, nel senso della disciplina, della professionalità, della qualità del suono. Muti, allora giovane direttore, compì un lavoro in profondità, senza il quale sarebbe stato impossibile per me procedere. A meno che mi mettessi io stesso a riorganizzare il tutto. Il lavoro di Muti e stato fondamentale, per rimettere l’orchestra nelle condizioni di effettuare quel ritorno culturale al repertorio tipico per il quale si era fatta apprezzare da Karajan e da Klemperer.

Posso dire con orgoglio che la Philharmonia, negli ultimi anni, è stata in grado di contrappuntare la famosissima registrazione di Tristano, realizzata con Furtwangler, con la registrazione di Tannhtiuser; nel 1994, registreremo Die Frau olzne Schatten, contrappuntando così il Rosenkavalier inciso da Karajan. Con la già effettuata incisione wagneriana, e con la futura incisione straussiana, condurrò l’orchestra inglese a riappropriarsi di un repertorio sostanzialmente di spettanza esclusiva, in questi ultimi decenni, dei Berliner Philharmoniker, dei Wiener Philharmoniker e della Sachsische Staatskapelle di Dresda. Affrontare un tale repertorio anche a Londra, per me è stata una grande conquista, il frutto di un lavoro lento e assiduo, diretta continuazione dell’opera di Riccardo Muti.
Un capitolo fondamentale della Sua attività con la Philharmonia è rappresentato dall’esecuzione delle opere di Mahler. Esiste una volontà di principio, nel Suo lavoro con questo autore, di scandagliare uno degli aspetti principali della cultura mitteleuropea di fine Ottocento inizio Novecento?
Attualmente, per me, il più sensazionale “strumento” per eseguire la musica di Mahler è la Filarmonica di Vienna. Immediatamente dopo, però, l’orchestra più accreditata per le esecuzioni mahleriane è la Philharmonia di Londra. Non soltanto perché è stata “educata” a Mahler da Otto Klemperer, uno dei più accreditati esecutori della musica di questo compositore, del quale fu discepolo. La Philharmonia, in questi ultimi anni, ha raggiunto un livello tecnico strepitoso, un virtuosismo e una qualità di suono di pari livello, sia negli archi che nei legni e negli ottoni. E stiamo ancora lavorando, per superare un livello già altissimo, per rendere il suono ancora più mitteleuropeo, ispirandoci come modello al suono della Filarmonica di Vienna. Spero di riuscire ad avvicinarmi ulteriormente alla sonorità specifica degli archi dei Wiener.
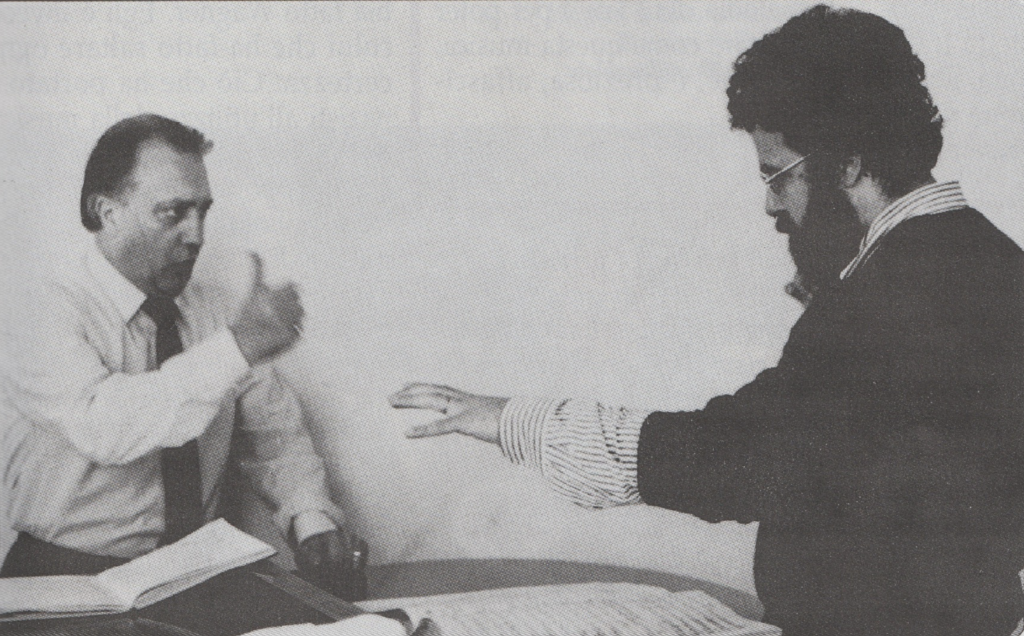

L’esperienza mahleriana con la Philharmonia è stata meravigliosa, sia per ampiezza che per intensità. La tournée giapponese è stata un’esperienza unica, come le molte esecuzioni della stagione al Royal Festival Hall e di altri viaggi sono state tutte indimenticabili, per me.
Una grande conquista, con la Philharmonia, è stata la Settima Sinfonia. La Settima di Mahler si sente raramente in concerto: è una pagina ingrata, difficile da “pensare”, da dirigere, da eseguire. La prima volta che ho diretto questa Sinfonia con la Philharmonia, gli orchestrali erano sgomenti. Sebbene avessero suonato con me già tutte le al tre Sinfonie di Mahler, fu un vero choc per loro ritrovarsi davanti a questa specie di sfinge impenetrabile. Pochi giorni or sono l’abbiamo incisa e sono stato davvero felice quando i musicisti mi hanno detto: «Abbiamoimpiegato cinque anni, ma ora, per noi, questa Sinfonia è diventata come la Prima, la Seconda, la Terza, come tutte le altre!».
L’importante, con un’orchestra, è svolgere un percorso coerente, oltre che continuato. E con la musica di Mahler, credo proprio che questo percorso l’abbiamo svolto. In dieci anni abbiamo sviluppato un modo di pensare, un modo di suonare questa musica, che è quello della chiarezza, del livello esecutivo, del rigore formale, a cui io tengo molto nelle esecuzioni mahleriane. A patto che esso sia legato a quel senso della perdita, dello smarrimento, dello straniamento, che sono tipici del mondo psicologico di Mahler.
Esiste una Sinfonia di Mahler indissolubilmente legata alla storia della Philharmonia di Londra, sia attraverso le mitiche versioni di Otto Klemperer, che attraverso le numerose interpretazioni che negli ultimi anni l’hanno quasi trasformata nell’inno di questa orchestra: la Seconda Sinfonia. Il primo luglio, Giuseppe Sinopoli e la Philharmonia hanno chiuso la stagione al Royal Festival Hall proprio con l’esecuzione di questa Sinfonia. Maestro, come definirebbe il fascino e il significato di questa composizione?

Lo concentrerei nel capovolgimento del motto di Schopenhauer “Leben um zu sterben”, “Vivere per morire”. Nel finale della Seconda di Mahler, invece, si canta “Morire per vi vere”. In questo scambio di direzioni si definisce la crisi della cultura tedesca e tutto l’essere di Mahler nella cultura tedesca stessa. In questo ambito, esisteva un pessimismo di fondo, che si individuava nel pensiero di Schopenhauer, secondo il quale il fatto della conoscenza era impossibile; se non si può conoscere, si deve rinunciarvi, e soffrire, con tutti gli uomini, di questa rinuncia. Se non si può conoscere, non resta che morire. Vuol dire, perciò, che si vive per morire. Mahler capovolge tutta questa problematica, in una specie di fideismo, in una grandiosa apertura di speranza, nel finale della Seconda Sinfonia. Il cammino viene quindi sviluppato nella Terza Sinfonia, una sorta di indagine sulle origini del mondo, nell’ambito della quale Mahler narra «ciò che raccontano la natura, gli animali, l’uomo, Dio».
Il senso della Seconda Sinfonia è questo: riaprire il mondo della speranza.
Parlando di crisi della cultura tedesca, esiste un compositore come Mahler che l’ha vissuta intermini interiori e privati. Altri musicisti di area tedesca, Wagner e Strauss, hanno vissuto le rispettive crisi in termini più proiettati verso l’esterno; i riflessi del loro operato sulla società tedesca sono stati particolari, al punto che la loro musica è stata associata alla problematica del nazismo.
Giuseppe Sinopoli, come vede quello che fu il fenomeno di assunzione dell’opera di questi due autori appunto da parte del nazismo?
Ritornando a Schopenhauer, non credo che la sua filosofia si possa definire di tipo nazista, né tantomeno ritengo che Nietzsche possa essere definito un filosofo nazista. E strano che si sia utilizzato Nietzsche quale emblema del nazismo, con l’appropriazione indebita di alcuni aspetti della sua terminologia. Cosa che non è successa a Schopenhauer; e il pensiero nietzschiano si basa proprio su Schopenhauer. E un fatto grottesco, quanto quello che ha visto assurgere a simbolo della politica sociale nazista il concetto di superuomo, dimenticando che tale concetto non è di tipo razziale, ma morale. Superuomo non è l’essere superiore agli altri, che lascia credere che esistano uomini inferiori da eliminare. Superuomo è l’essere che riesce a superare se stesso dal punto di vista morale, nel senso della conoscenza. Se i nazisti avessero colto bene il significato della filosofia di Nietzsche, non l’avrebbero utilizzata.
Il caso della musica di Wagner è altrettanto paradossale e ridicolo. Non vedo sotto quali aspetti la musica di Wagner possa essere nazista. Non lo è sicuramente nella sua grammatica musicale, né nel suo carattere, addirittura disgregante, né nella natura della sua costruzione, attraverso il sistema del Leitmotiv. I meccanismi di questo autore non coincidono con i princìpi di un’estetica di tipo nazista. Un compositore allineato con i princìpi del nazismo, avrebbe dovuto applicare princìpi meno rivoluzionari e disgreganti di quanto non abbia fatto Wagner. Egli è invece colui che ha fatto saltare ogni certezza. Ciò che ha portato i nazisti all’utilizzo della musica di Wagner è la stessa ignoranza che li ha portati a servirsi, come loro simbolo, della svastica. La musica di Wagner è stata impiegata dai nazisti facendo riferimento unicamente alle vicende narrate dai libretti, nell’ambito dei quali si raccontano storie legate all’antica mitologia germanica. Da essi hanno recuperato quell’idea di celebrazione della morte come unica possibilità dell’amore, in chiave, ancora una volta, schopenhaueriana. Essa è stata trasferita nell’ambito di una delirante concezione della morte come olocausto, ovvero il sacrificio supremo nell’ambito di una totale dedizione allo Stato. Morire per lo Stato significava essere lo Stato: raggiungere l’estrema sublimazione dell’essere uomo nello Stato, che è il momento più alto nell’idealismo estremo di destra. Da qui alla legittimazione dell’eccidio, il passo è breve.
Il fatto più inquietante, per me, nella cultura nazista, è stato quello di impiegare dei materia al di là della conoscenza dei materiali stessi. La svastica è un segno colmo di simbologia: è stato usurpato da un’ideologia di volgarità, di morte e, soprattutto, razzista. Wagner poteva essere anche il più grande antisemita di questo mondo, come poteva scrivere di antisemitismo: la sua musica, però, non contiene elementi antisemitici.
E Richard Strauss?
Nel caso di Strauss, Hans Swarowski ripeteva in continuazione che egli aveva nascosto in casa sua anche degli ebrei, per salvarli dalla persecuzione nazista. Swarowski, che era molto legato a Strauss, raccontava anche come, dal punto di vista ideologico, egli fosse tutt’altro che un fiancheggiatore del regime, anzi! Se la musica di questo autore è stata utilizzata dai nazisti, ciò è avvenuto, ancora una volta, al di là della sua comprensione: di essa si coglieva solamente il carattere spettacolare e celebrativo, magari travisando il senso di pagine come Così parlò Zarathustra, direttamente ispirato a un lavoro di Nietzsche. Strauss, oltretutto, era il maggiore compositore dell’epoca e quindi l’esecuzione della sua musica in vesti ufficiali portava acqua al mulino della propaganda nazista.
A proposito dell’impiego della musica di Wagner, sembrerà paradossale, ma oggi più che ai tempi del nazismo essa può suscitare insani atteggiamenti nazionalistici. Per due ragioni: la prima legata al nazionalismo che oggi sta assumendo toni assai intensi; la seconda è legata alla prima: chi oggi inneggia alla razza pura con la musica di Wagner, pensa all’uso di questa musica nel momento in cui tale discorso ebbe il suo massimo sviluppo.
Un’esperienza fondamentale, per un wagneriano, credo sia quella di dirigere nel teatro di Bayreuth. Lei è stato il primo direttore italiano a essere invitato a Bayreuth, dopo Arturo Toscanini e Vietar de Sabata; Come ricorda il Suo debutto nel teatro sulla Griine Hiigel, la collina verde, nel 1985?
I lavori che finora ho diretto a Bayreuth, non erano stati “pensati” per quel luogo. Spero di aver l’occasione di dirigervi un repertorio diverso, e così di entrare in sintonia, di trovare quelle magiche coincidenze che rendono assolutamente mirabile l’esperienza che un direttore d’orchestra può vivere in quel luogo.
Comunque, anche dirigendo opere come Tannhèiuser e l’Olandese Volante, non espressamente concepite per quel teatro,
ne ho subìto il fascino immenso, il quale deriva soprattutto dal fatto che il suono viene raccolto nella conchiglia che sta sopra l’orchestra e proiettato in avanti, e dal fatto che orchestra e direttore sono completamente isolati dal pubblico. Questa situazione di totale distacco obbliga il direttore a confrontarsi con se stesso e a provare la propria onestà professionale. Personalmente, non mi sono mai esercitato nella ricerca di una bellezza del gesto, ragion per cui a Bayreuth mi sono trovato a mio agio. Il suono che, a differenza di ogni altro luogo, dopo essere

stato proiettato sul fondo della scena, ritorna al direttore d’ orchestra combinato con quello della voce dei cantanti e del coro, ti investe letteralmente, creando un contatto quasi fisico, materico, molto più compromettente di quello che si avverte dirigendo in un normale teatro d’opera. Posso immaginare che una musica come quella di Parsifal, nella sua ossessiva circolarità, riesca a creare, se diretta a Bayreuth, sensazioni straordinarie, un contatto tale con le onde sonore da far vivere un’esperienza irripetibile.
Esiste un collegamento fra l’estetica musicale di area tedesca tardo-ottocentesca e quella italiana del medesimo periodo, che si identifica in Puccini. Dei direttori italiani in attività, Lei è quello che si è occupato di più di questo autore. A Puccini sono legati alcuni dei Suoi primi successi, in teatro; le sue edizioni discografiche di Manon, Madama Butterfly e più recentemente Tosca, sono diventate dei punti di riferimento. Il Suo interesse per Puccini si può far rientrare nel discorso che prima si faceva a proposito del Decadentismo di fine Ottocento nella Mitteleuropa?
Indubbiamente la coincidenza dei miei interessi per Puccini non è casuale. I problemi esistenziali della perdita dell’identità che viveva la Vienna a cavallo fra Ottocento e Novecento erano legati al fatto che, seguendo l’idealismo di destra di cui prima si diceva, per il quale esisteva un’identificazione a livello metafisico fra uomo e Stato, il crollo della monarchia si è trascinato con sé tutti i valori politici, filosofici e morali. Tale perdita di valori esistenziali nella Mitteleuropa ha il suo corrispondente in Italia nel crollo dei valori della borghesia, che dal punto di vista musicale trova il suo principale interprete in Puccini.
Puccini era il compositore della piccola borghesia, con tutti i suoi problemi. Ma Puccini non affronta solo queste tematiche. In Tosca, ad esempio, egli affronta argomenti che hanno poco a che vedere con la piccola borghesia e con il Verismo, a cui troppo spesso si vuole accostare Puccini. Si affronta il problema del rapporto fra potere, Stato e Chiesa, che viene scandagliato in tutto il primo atto, fino al fantasmagorico finale, con il “Te Deum” che è la conclusione dell’urlo di potere di Scarpia, attraverso il quale egli aggredisce anche gli affetti privati.
Quanto al presunto Verismo di Puccini, basterebbe una scena della Fanciulla del West per dimostrare quanto la sua estetica, la sua orchestrazione, siano distanti da ciò che ha espresso per esempio Mascagni in Cavalleria. Si tratta della scena del ballo dei minatori: la musica che la sorregge non è certo da “valzer dei minatori”, ma rievoca il sogno di questi minatori, i quali immaginano una città lontana, magari una festa in un salone Jugendstil, che loro non sanno nemmeno come sia in realtà. Ciò che si sente nell’orchestra, in quel momento, è completamente diverso da ciò che si vede sulla scena. Da un ipotetico Verismo si slitta quindi, con Puccini, verso una dimensione onirica, trasfigurata.
Si pensi anche all’inizio del terzo atto di Tosca: dopo il canto del pastorello, le campane non sono fatte risuonare in chiave verista. Hanno una funzione evocativa: passare dalla notte, che è ancora il momento del possibile (la sorte di Cavaradossi non è ancora segnata, almeno in apparenza), al momento dell’attesa, delle certezze, della morte e quindi del distacco. L’orchestrazione di Puccini è totalmente allusiva, molto mediata, di una raffinatezza di timbri che conduce da una dimensione naturalistica a una dimensione sottilmente evocativa.
La Sua inclinazione mitteleuropea si è identificata sia in un viaggio fisico a Vienna, sia in un viaggio spirituale in quella città. La Sua risposta a questa “viennesità” profonda, nel momento in cui ha iniziato la carriera di direttore d’orchestra, non è stata nel segno della continuità, non ha affrontato Wagner, Mahler, Puccini, Strauss, ma soprattutto il “primo Verdi” di Nabucco, Attila, Macbeth. Come spiega questo Suo dedicarsi a un aspetto della musica così distante da quello in cui Lei era cresciuto, artisticamente?
Il mio avvicinamento al giovane Verdi nasceva da un’esigenza di purificazione. Quando ho iniziato a dirigere questo repertorio, stavo giungendo al termine della mia parabola come com positore. Almeno, della mia prima parabola, se un giorno continuerò. Tale percorso creativo era molto strutturato e mi ha condotto a realizzare una specie di parafrasi onirica della Nuova Scuola di Vienna, fino a giungere alla mia opera Lou Salomè. Il fatto di accostarmi alla direzione d’orchestra e soprattutto di affrontare il “primo Verdi” significava realizzare una specie di ricerca della concretezza, una sospensione da questo labirinto della parafrasi della Scuola Viennese, della rievocazione mitteleuropea. Mi interessava una dimensione affettiva come quella di Verdi, concentrata com’è in una materia infuocata, di un fuoco bianco però. Il giovane Verdi ha la capacità dell’arte povera: il minimo di mezzi per il massimo di messaggi. Le sue prime opere contengono, nel minimo della materia compositiva, il massimo dell’esperienza drammatica. Questa specie di riduzione della materia alla sua più grande violenza espressiva mi affascinava: era esattamente il contrario dell’ambito artistico in cui mi trovavo a operare in quel momento, costituito dalla massima sofisticazione formale, armonica e timbrica, che impiegava un’orchestra immensa.
Il ritornare a questa semplificazione del segno, a questo rapporto inversalmente proporzionale fra dimensione del segno e dimensione del significato, la sentivo estremamente salutare.

Il Suo approccio alla direzione d’orchestra non è mai avvenuto attraverso un atteggiamento edonistico, alla ricerca del virtuosismo fine a se stesso. Prima di giungere sul podio, Lei ha affrontato studi di diverso tipo, si è laureato in Medicina, ha svolto un’attività di compositore, si è interessato di molti altri aspetti del mondo culturale.
Oggi Lei sviluppa due percorsi: accanto all’intensissima attività di direttore d’orchestra, affianca la ricerca nel campo archeologico, in uno studio sistematico finalizzato a una laurea in questa disciplina. La precedente fase “medica”, l’attuale fase “archeologica” dimostrano che non ha mai diretto solamente per il gusto di dirigere.
Sono arrivato alla musica da questo tipo di contesto, perché non è esistita per me un’altra possibilità. Se non avessi avuto questi interessi culturali, la musica non mi sarebbe mai interessata. Perché mi interessa la musica? Perché nella musica esiste questa specie di iato fra il valore espressivo e il valore conoscitivo. La musica si muove costantemente fra gli estremi dell’espressione e della conoscenza. Ma la musica si può veramente conoscere? Attraverso il suo studio sistematico, si tenta di raggiungerne la totale conoscenza, ma ci si accorge che, oltre a un certo limite, con i mezzi dell’intelletto non ci si può più spingere. La ricerca così sfocia nel silenzio. Proprio da questo silenzio scaturisce il fatto miracoloso della musica, quello espressivo. La musica possiede, cioè, quello che non possiede la conoscenza, vale a dire l’espessività. Per capire fino in fondo la musica, si ha bisogno dell’espressività. E l’espressività è la più inquietante sirena, che fatalmente attira verso la musica.
Una delle musiche più inquietanti che esistano è il Don Giovanni di Mozart. Posso immaginare che per Lei, Maestro, con la Sua passione per lo studio dei miti e dei simboli, il Don Giovanni rappresenti un’affascinante sirena. Ma per il momento, Lei non ha praticamente diretto la musica di Mozart. Cito una Sua frase: «Mozart è come il mare, per me: lo adoro, ma non so nuotare»…
E lo confermo. Sono sicuro che, un giorno, dirigerò Don Giovanni. Ma solamente quando avrò imparato a nuotare. Forse avrò imparato quando avrò iniziato il mio ritiro nelle Isole Eolie, un posto completamente attorniato dal mare, e non da concerti e da tanti viaggi…
La musica di Mozart è la musica più irraggiungibile che esista e credo che, nella parte della mia vita in cui non dirigerò più molto, Mozart sarà uno di que gli autori che affronterò. Per dirigere Mozart, ci vuole molto pensiero, molto coraggio, molte rinunce, molto tempo. Penso proprio che per me il tempo di Mozart verrà più in là.
Non mi interessa un Mozart gestuale, emozionale, con un bel suono e basta. Il problema di “conoscere” Mozart è simile a quello di “conoscere” il segreto di come un tempio greco, apparentemente simmetrico, in realtà è asimmetrico. La musica di Mozart è simmetrica solamente in apparenza. Di fatto, il periodo musicale è asimmetrico: le frasi e il completamento delle frasi sono asimmetrici.
Il problema dei rapporti fra simmetria e asimmetria è uno dei più complessi dell’antica Massoneria: questo porsi fra simmetria e asimmetria, questo oscillare fra i due aspetti in musica è estremamente difficile da realizzare, perché nella musica si ha bisogno del suono. “Quel” suono lo si riceve dall’orchestra, quando essa sente che il direttore ha capito il problema. Ciò si verificava nei momenti più magici di quando musicisti come Karajan o Bernstein erano sul podio.
Esiste un compositore, che Lei frequenta assiduamente, addi rittura ossessionato dai proble mi di simmetria nell’ambito della forma: Anton Bruckner …
La musica di Bruckner è pienamente simmetrica: è una musica delle proporzioni, dei rapporti fra numeri, fra il tre e il quattro, fra l’uno e il due, e dei loro significati. E volutamente simmetrica. Un’altra musica disperatamente simmetrica è quella di Beethoven. Esiste, in questo autore, una volontà titanica di costruzione, di creare una specie di sistema di proporzioni assolute fra le parti. La musica di Beethoven è esattamente l’opposto di quella di Mozart, sotto questo aspetto. Essa però non sembra così simmetrica, come invece effettivamente è. In questo senso, Beethoven è un compositore affascinante, che ho avvicinato lentamente, negli ultimi cinque anni, e che sto attualmente indagando. Questa vo lontà dallo slancio epico di Beethoven di cercare in tutti i modi di raggiungere la proporzione nelle forme, si proietta sia nelle macrostrutture che nelle microstrutture: l’estremamente piccolo che si rispecchia nell’estremamente grande, e vice versa. L’esempio più travolgente di questo sistema – di partire da microcellule ritmiche e intervallari, per irradiare verso un’amplissima struttura – è da to dalla composizione della Nona Sinfonia.

Lei ha diretto, in questi ultimi tempi, due importanti lavori del Primo Ottocento: lo Stabat Mater di Rossini (prima con la Philharmonia a Londra e poi con i Wiener Philharmoniker a Vienna) e la Creazione di Haydn (a Roma e a Dresda non molti mesi fa). Da una parte, la morte “tranquilla”, ma estremamente drammatica, la cui evocazione è contenuta nello Stabat Mater rossiniano; dall’altra, l’inno al farsi del mondo e alla vita della Creazione haydniana.
Lei parla di morte “tranquilla” ma estremamente drammatica, riferendosi all’opera di Rossini. Ci stavo proprio pensando negli scorsi giorni, a Vienna. E un lavoro che mi ricorda un vaso corinzio con un fiore dentro: mi riferisco alle processioni mortuarie, quelle specie di processioni di animali, della trasformazione, della mediazione, della forza.
È presente questa bellezza naturale, vissuta da Rossini con grande purezza, come nel “Paradisi gloria”. La drammaticità, il terrore, l’orrore della morte sono rappresentati in questo lavoro dall”‘In sempiterna saecula”, un momento che assimila lo Stabat Mater al Requiem di Verdi. Si parte da un sentimento di dolore umano, quasi popolare, come nell’aria del tenore. Questo sentimento di perdita, riferito al dolore della madre per il figlio, si trasforma strada facendo in una specie di orrore depressivo della morte, di paura del vuoto, che riflette le crisi maniaco-depressive di cui Rossini soffrì si stematicamente, per tutta la vita ma soprattutto nell’ultima parte. Passando alla Creazione di Haydn, devo dire che il repertorio oratoriale continuerà a interessarmi. Ho già diretto Il Para diso e la Peri di Schumann, e di questo autore mi interessa anche Faust. Di Haydn, vorrei affrontare anche Le Stagioni. Si tratta di un’indagine in quel mondo espressivo che sta fra l’opera e il genere sinfonico: rappresenta un’astrazione della vocalità, una sorta di sublimazione degli affetti verso la realizzazione di una drammaturgia più indiretta. Nel caso della Creazione, mi affascina in particolare quel senso dello stupore quasi mistico, ottenuto con un’enorme chiarezza, una semplificazione assoluta del gesto: quella sorta di stupefazione nell’osservare il farsi del creato, l’apparizione dei vari mondi che compongono il creato, dalla natura all’uomo. Nel lavoro di Haydn, mi affascina questa epifania, questa osservazione quasi rituale dell’apparire delle cose. E in sé, come argomento di riflessione: l’uomo che prova stupore per come si manifesta la forza della divinità.
Maestro, la Sicilia La affascina, anche perché è la terra da cui proviene (Suo padre è siciliano); ad essa ha reso omaggio con l’incisione di Cavalleria Rusticana. Si è anche impegnato nella direzione musicale della sezione “Musica e Danza” del Festival “Taormina Arte”. Due anni fa, Lei ha diretto Salome di Strauss in forma di concerto, lo scorso anno è stata la volta di Lohengrin in forma scenica, quest’anno si ritornerà a Strauss con Elektra. A livello di sensazioni, il fatto di dirigere in quel teatro greco, al quale sono idealmente destinate tali opere “mitologiche”, cosa fa provare al direttore Giuseppe Sinopoli?
Ho provato innanzitutto una grande soddisfazione, in particolare per essere riuscito a portare, lo scorso anno, quel Lohengrin, un prodotto di altissimo livello tecnico, in un posto dell’Italia considerato poco adatto a manifestazioni culturali di rango. Si è trattato di uno dei migliori spettacoli che siano stati prodotti nel nostro paese. Un grandissimo coro, come quello di Bayreuth, una grandissima orchestra, come la Philharmonia, un grandissimo cast sono stati gli ingredienti di uno spettacolo prodotto in Sicilia. Questo mi riempie di orgoglio.
E non si può dire che l’iniziativa sia funzionata solamente per merito di coro, orchestra, cantanti, oltre a Wolfgang Wagner e a me, perché è stato determinante l’apporto delle forze del posto. Questo Festival, fatto da siciliani, è una cosa sorprendente. Wolfgang Wagner mi diceva che se a Bayreuth potessero disporre di un simile staff, la loro attività funzionerebbe ancora meglio di quanto già non succeda.
Dal punto di vista puramente emozionale e spirituale, esiste il fascino di tornare in un luogo come un teatro greco, dove si ricreava il mondo, dove la tragedia che veniva recitata aveva sostituito la manifestazione dei Misteri, i quali a loro volta avevano sostituito la comprensione dei simboli. La decifrazione dei valori simbolici, con il diminuire della conoscenza, si era trasformata nel mito e quindi nel rito. Dal rito si è poi passati ai Misteri e quindi alla tragedia. Ciò che ha condotto dalla comprensione dei simboli alla tragedia è un processo di progressivo oscuramento del sapere. Rifare della musica in un luogo come il Teatro Greco di Taormina, destinato al recupero del sacro, come gli altri teatri, è un’ esperienza affascinante.

Come ricorda, a un anno di distanza, il Suo debutto alla Scala, in un concerto con la Filarmonica dedicato a Strauss?
È stato un avvenimento che mi ha toccato in modo particolare. Al punto che preferisco lasciar passare parecchio tempo, prima di ripetere l’esperienza. Ritornerò sul podio della Scala, con la Filarmonica, solamente il prossimo anno. Tale avvenimento è stato molto importante, per tutta una serie di ragioni. Ciò che mi ha commosso di più a Milano, è stata la libertà, la disponibilità mentale del pubblico, che ha reso possibile tale successo. Molti milanesi prima di quel momento, anche se non mi avevano mai visto dirigere alla Scala, probabilmente mi conoscevano già attraverso i dischi e i concerti in altre parti del mondo. Spesso trovo dei messaggi in camerino, o incontro persone che vengono a salutare, a Londra, a Vienna, a Berlino o a New York. Quando sono italiani, si tratta solitamente di milanesi. Ciò che mi ha profondamente toccato, nell’incontro con il pubblico della Scala, è stata la grande disponibilità a entrare in contatto con il mio modo di pensare la musica, di fare la musica. L’ho capito in particolare da quei silenzi assoluti durante l’esecuzione, dal modo di essere delle persone che si trovavano in sala. Era come se ci fossimo già incontrati, come se ci conoscessimo da sempre. E’ meraviglioso accorgersi che si è apprezzati per quello che si è e che il pubblico ascolta al di fuori di qualsiasi preclusione e preconcetto.

Finora Lei si è espresso attraverso la composizione e la direzione d’orchestra. Recentemente si è dedicato alla saggistica. Il Suo libro, Parsifal a Venezia, è la narrazione di un ampio percorso mentale, legato a un’esperienza affascinante come la direzione dell’opera wagneriana a Venezia nel 1989. Come è nata l’idea di scrivere Parsifal a Venezia?
Il saggio è nato durante il periodo delle prove e delle esecuzioni di questo Parsifal. Non si può dirigere una tale opera semplicemente pensando solo alla musica: molti altri aspetti devono essere tenuti presente. Bisogna pensare alla bugia contenuta nel Parsifal wagneriano, e alla grandezza di quest’opera. La bugia è legata a quel sentimento di disfacimento intellettuale, che era quello che dava a Nietzsche i motivi per giudicare Parsifal come una materia da operetta. La grandezza si deve all’enorme e irragiungibile livello espressivo della musica wagneriana. Secondo Nietzsche, anche a persone di conoscenze superiori, Il Parsifal riusciva difficilmente comprensibile.
Parsifal si muove dunque nell’ambito di questo rapporto ambiguo fra bugia e verità, fra morte e vita. Esso si riflette da una parte nella dimensione sacrale del tempo, che è propria della musica del Parsifal, e dall’altra nel contenuto triste, grigio, pesante, pervaso da un fastidioso senso di colpa e di rimorso, in netto contrasto con la solarità travolgente della mitologia del Parsifal prima di Wagner. Proprio la constatazione di questa ambiguità, di questa proiezione della mitologia del Graal nell’ambito di una visione cristiana, mi ha guidato a riflettere sul concetto di rinascita che le è proprio. La simbologia della lancia e la simbologia della coppa, così tipiche della rinascita, trovano dei riferimenti, diretti e indiretti, nella struttura di Venezia, nelle sue pietre, nelle calli, nei sottoporteghi. Il libro è nato, quindi, perché mi sono trovato a vivere in una situazione esteriore e interiore dominata da quest’idea della rinascita e dai suoi simboli.
a cura di Fernando De Carli
